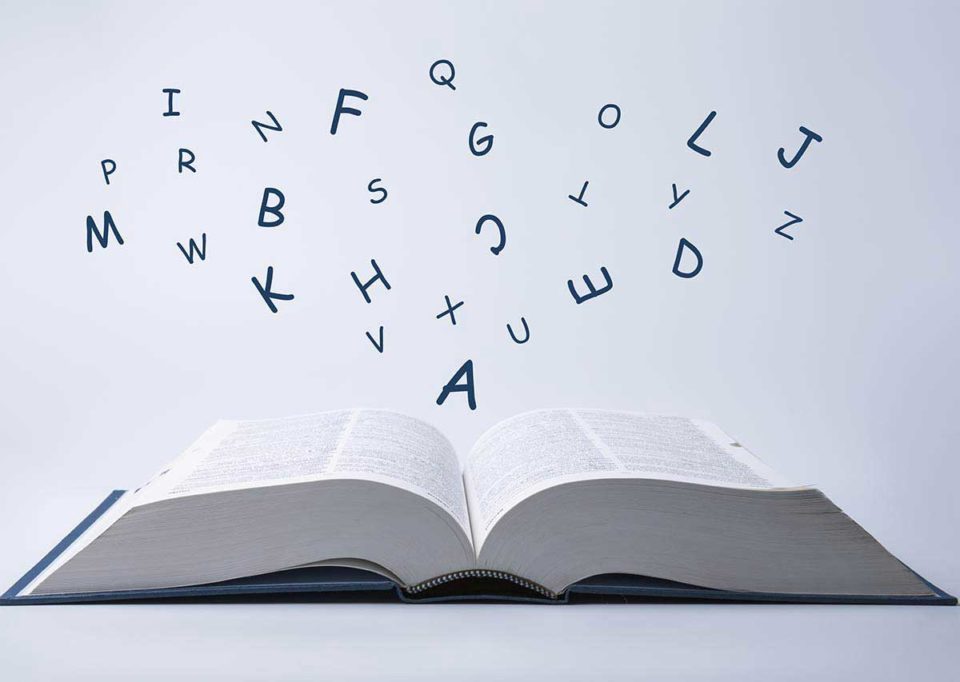La lingua universale è la traduzione: geopolitica del multilinguismo

Cos’è un termbase e a cosa serve?

Remote Simultaneous Interpreting (RSI): come è cambiato l’intepretariato durante la pandemia?
Quando Ursula von der Leyen ha pronunciato il suo discorso al Parlamento europeo il 16 settembre 2020, ha rotto la tradizione. Ha parlato in francese per quasi quattro minuti in due sezioni all’inizio e alla fine del discorso. Ha usato il tedesco per nove minuti e mezzo a metà del suo discorso. E ha parlato in inglese per un’ora e tre minuti in totale.
L’equilibrio delle lingue nel Parlamento è stato sconvolto. La Von der Leyen ha scelto l’inglese come lingua pragmatica del suo ufficio; il suo uso delle altre lingue tradizionali della Commissione era puramente una questione di comune cortesia. Eppure, dopo la Brexit, su 751 membri del Parlamento europeo, ci sono solo una ventina di madrelingua inglese. Jean-Luc Laffineur, presidente dell’associazione GEM+, che promuove il multilinguismo nelle istituzioni europee, ha commentato la questione su La Libre Belgique, notando che l’inglese è la lingua madre dell’1,5% della popolazione dell’UE, mentre solo il 10% dei cittadini europei lo parla ad un livello molto alto.
Come scrive l’Observatoire Européen du Plurilinguisme: “Si dà il caso che i funzionari della Commissione europea, qualunque sia la loro prima lingua, siano portati a produrre testi esclusivamente in inglese da circa vent’anni. Sono di fatto impiegati come traduttori di primo livello pur non essendo tali”. La traduzione automatica potrebbe forse modificare questa tendenza di riduzione linguistica, permettendo ai funzionari della Commissione, così come ai membri del Parlamento, di parlare e scrivere nella propria lingua senza ostacolare la circolazione dei testi all’interno dei servizi e ai vari livelli gerarchici. L’automazione e la ricchezza della diversità linguistica non sono in contrasto, anzi, il contrario.
Fino all’agosto 2020, il Ministero dell’Educazione in India ha raccomandato di dare priorità all’insegnamento di cinque lingue straniere nelle scuole: Francese, tedesco, spagnolo, cinese e giapponese. Da agosto, il cinese non è più nella lista. Nel frattempo, il ministero ha monitorato le fonti di finanziamento per le scuole cinesi in India. Queste mosse fanno parte del conflitto culturale ed economico che oggi separa India e Cina. Questo conflitto comprende anche un centinaio di applicazioni cinesi che sono state vietate in India, così come la risoluzione dei contratti con le aziende cinesi che si occupavano di grandi infrastrutture.
Nel frattempo, la Cina ha diluito l’importanza dell’inglese nell’insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria. Nel giugno 2020, il Ministero dell’Educazione ha deciso di cambiare i suoi programmi aggiungendo il tedesco, il francese e lo spagnolo alle lingue insegnate fino a quel momento (inglese, giapponese e russo). Tutte le scuole dovranno insegnare almeno due lingue straniere. Il francese è anche incluso come una delle materie opzionali per l’esame di ammissione all’università (GaoKao). In un discorso tenuto al Palazzo Daming di Xi’an durante la sua visita di stato nel 2018, il presidente Emmanuel Macron si è rivolto agli studenti cinesi che imparano il francese, dicendo: “Avete fatto la scelta giusta. Conoscere il francese sarà un vantaggio nel vostro futuro”. Il fatto è che l’inglese rimane la priorità: ha sostituito il russo nella maggior parte dei corsi di studio cinesi, è studiato da 400 milioni di alunni cinesi e gioca un ruolo essenziale nel GaoKao. Tuttavia, il modo in cui l’inglese viene appreso in Cina si concentra principalmente sulla lettura e meno sulle capacità di ascolto e di conversazione.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Linguistici, prodotta nel 1996 da ONU e UNESCO, garantisce la legittimità fondamentale di tutto ciò che può aiutare a sviluppare un approccio multilingue per le comunità umane. All’epoca, quei principi sembravano forse giusti da sostenere ma impossibili da attuare. Tuttavia, con l’avvento della traduzione automatica e il potere delle piattaforme che permettono di collaborare allo sviluppo della comunicazione interculturale e multilingue, i principi della Dichiarazione si sono improvvisamente dimostrati realizzabili.
La complessità prevarrà sulla semplificazione nel futuro delle lingue. Inoltre, le lingue nazionali sono difese da un punto di vista politico contro la “colonizzazione” linguistica, e questo fenomeno non sembra destinato a cessare. Il pragmatismo che porta l’inglese globale a conquistare spazi nella politica o nella scienza è quindi almeno altrettanto forte della dinamica che alimenta la vitalità delle lingue locali. Grazie al miglioramento dei servizi linguistici aumentati dall’automazione e dal supporto di strumenti digitali sempre più potenti con interfacce vocali, in un ambiente dominato dalla comunicazione mediatica digitale, potremmo avvicinarci al punto in cui l’idea di Umberto Eco diventa realtà e “la lingua universale è la traduzione”.